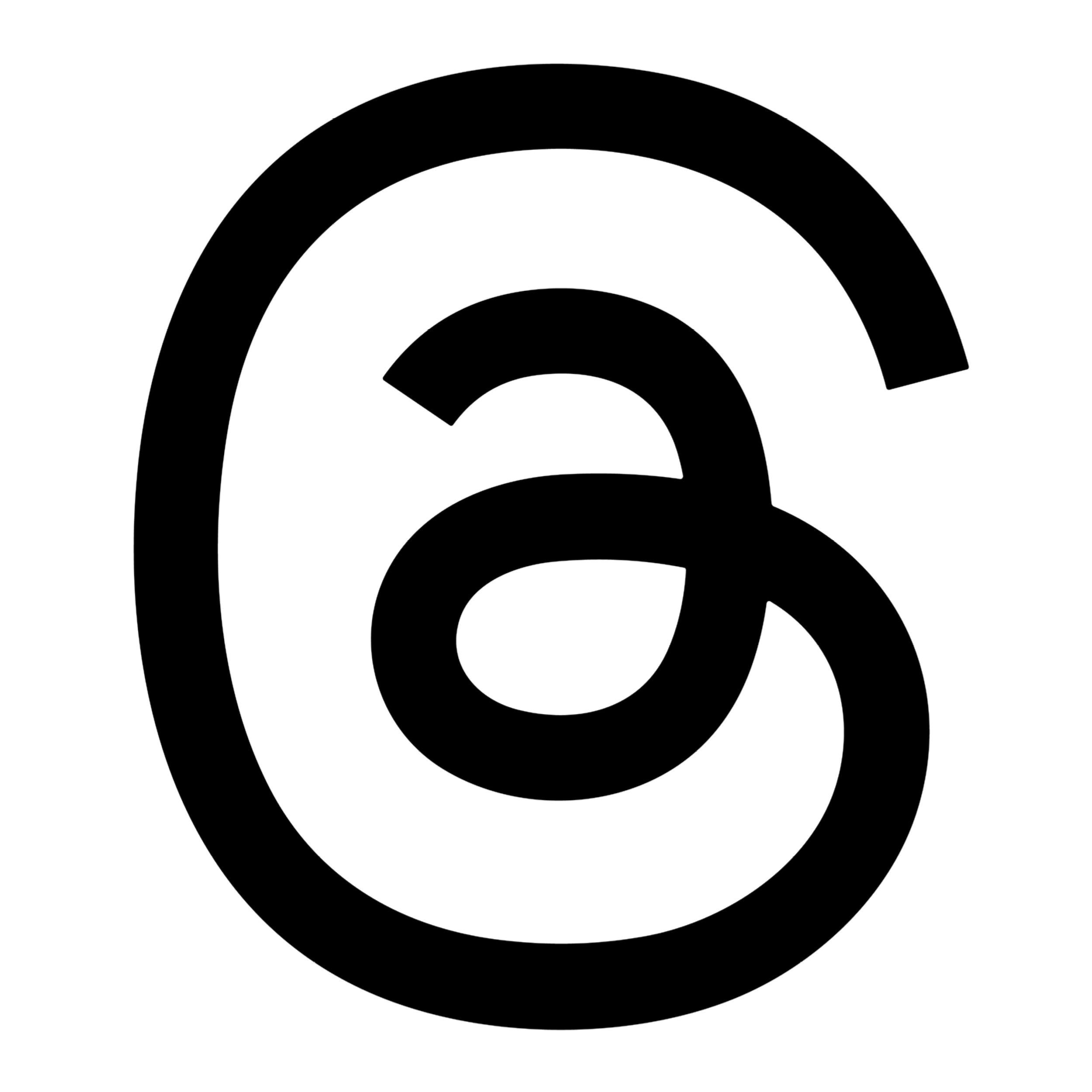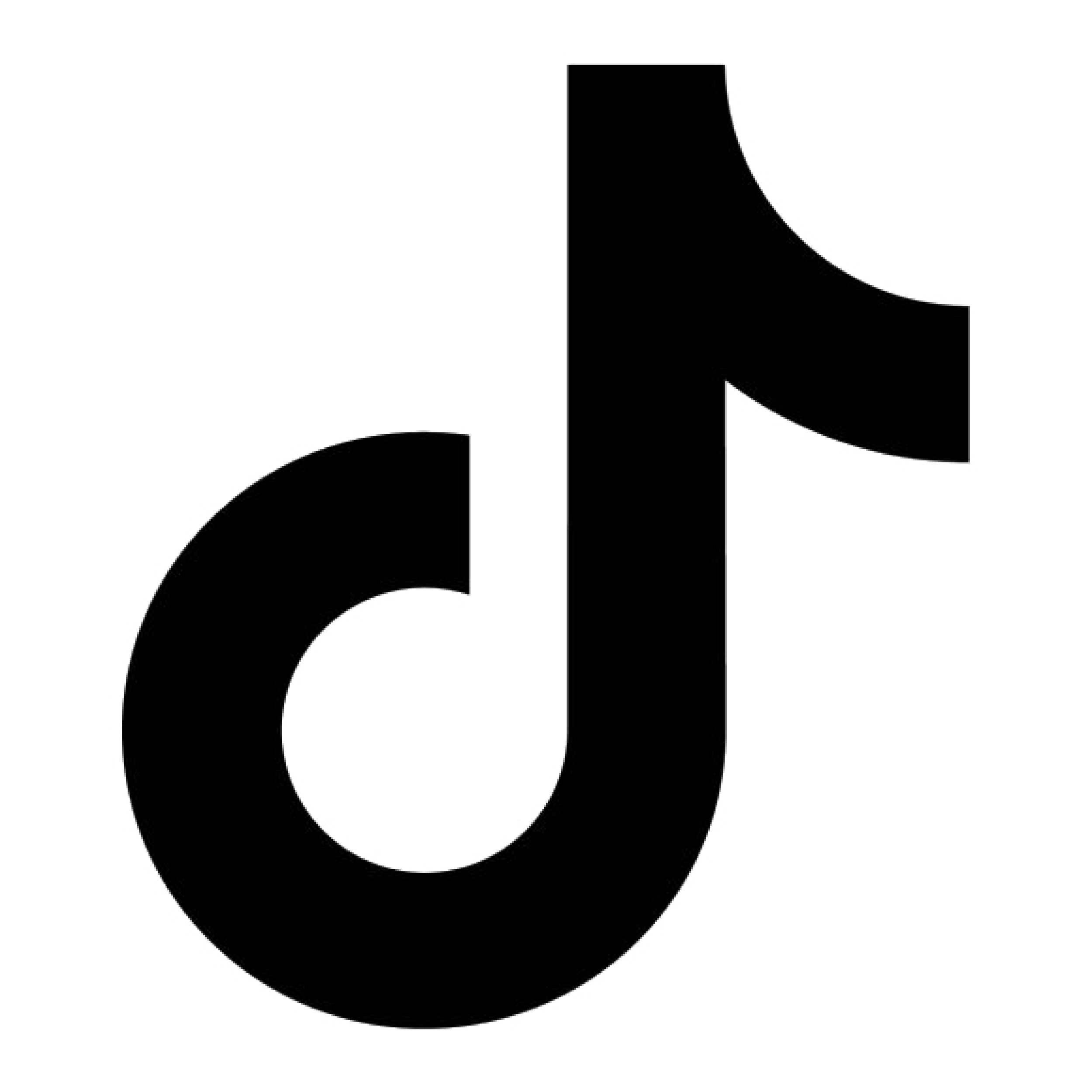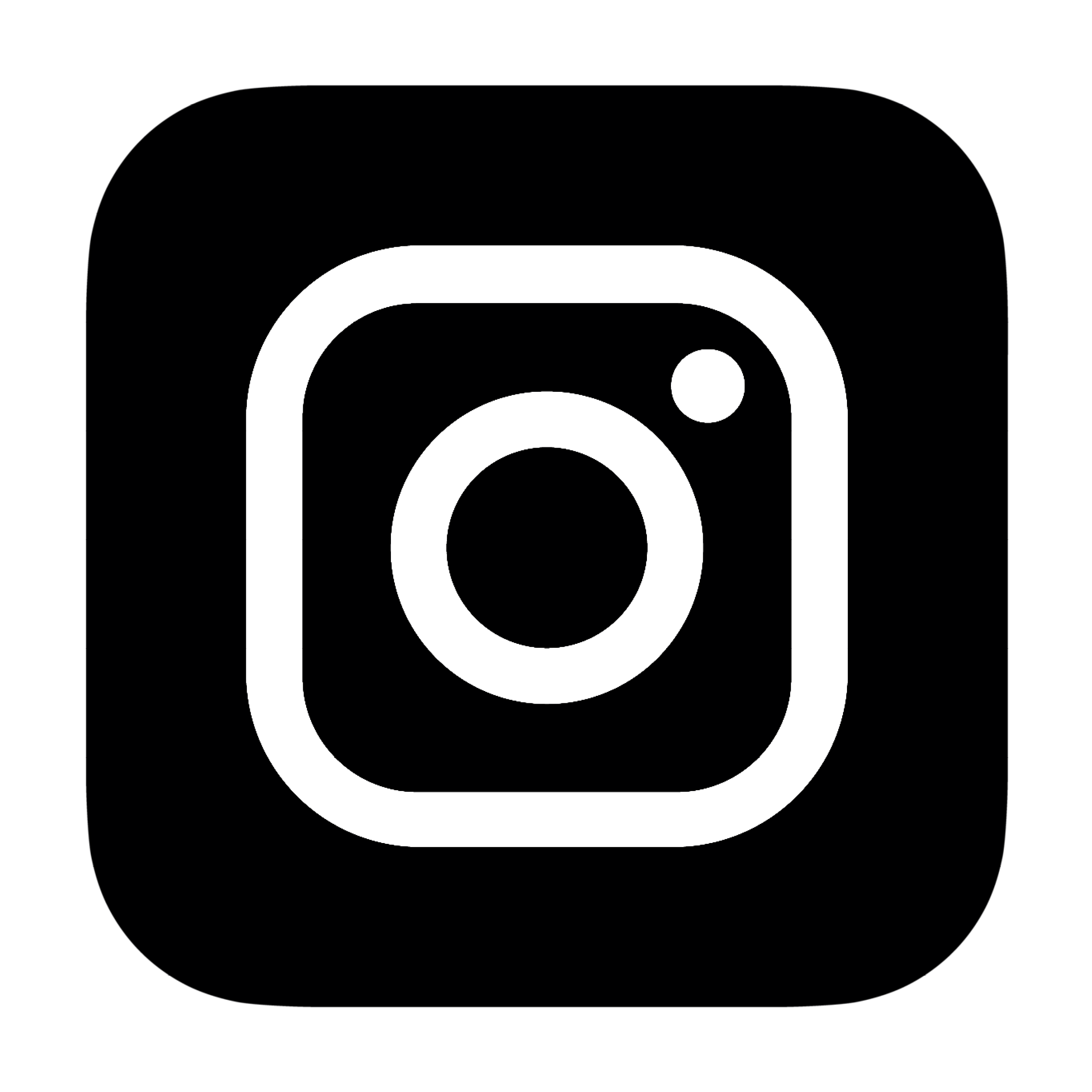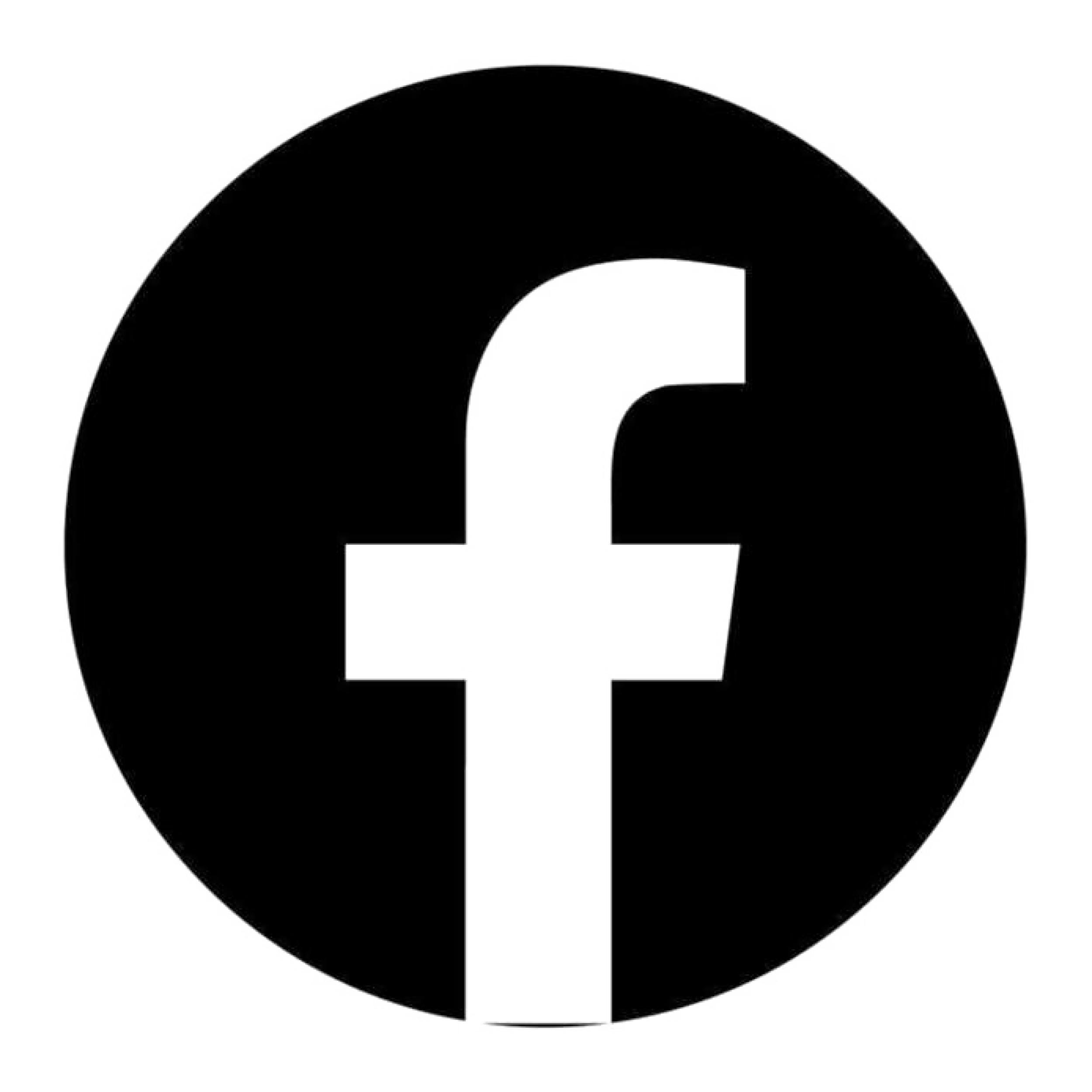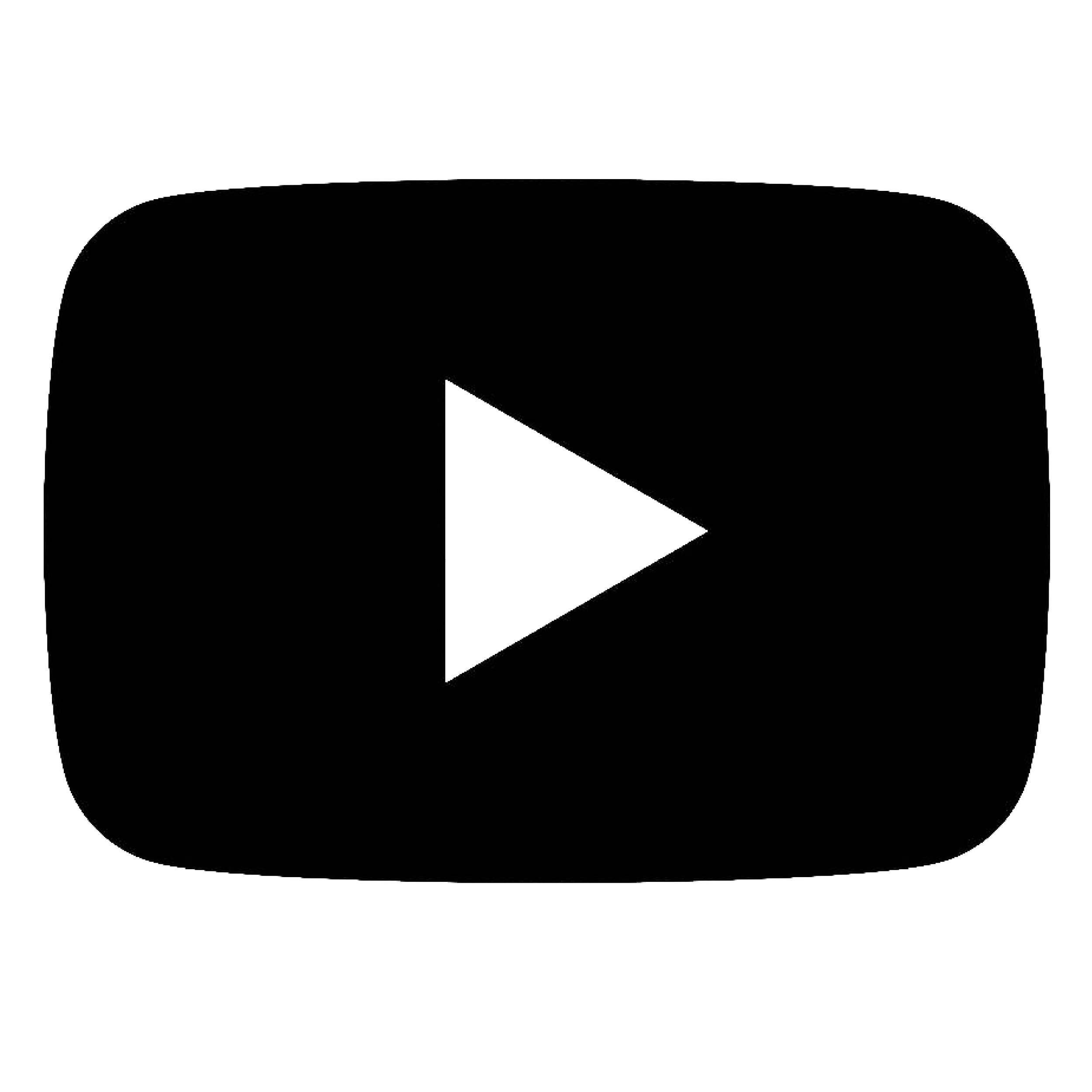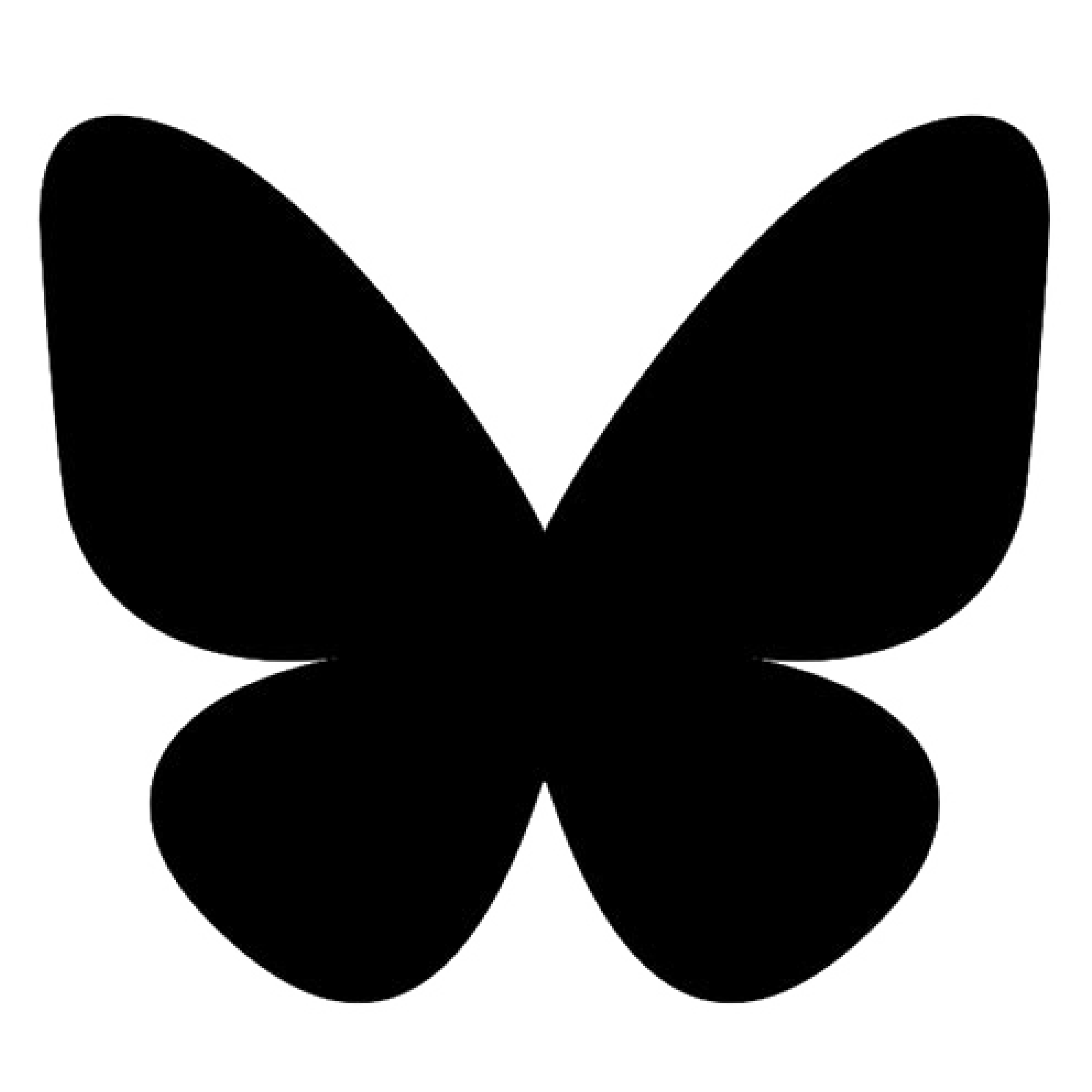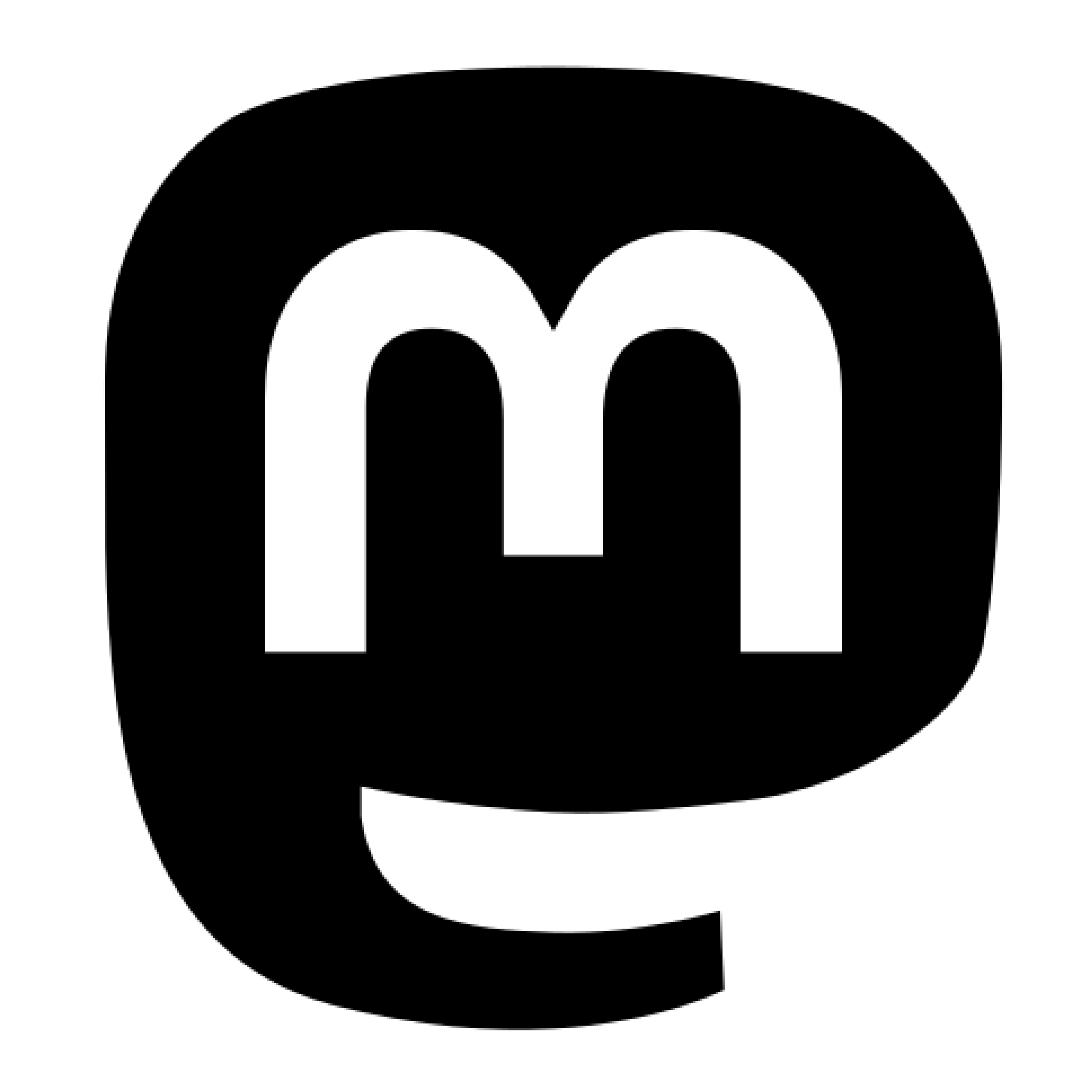Anyone who plays music knows that an allegro at the beginning or end of a sonata, symphony, quartet or concerto does not denote high-spiritedness. That is, it does not declare or impose or suggest a mood, but rather a tempo. Some allegros convey torment and turmoil, others frenzied drama — and it wouldn’t occur to anyone to consider them cheerful.
A composer like Prokofiev is an exception. His allegros ring with joy even in the state-commissioned pieces, as if they were actually smiling, or pretending to smile, which was often equivalent in that lugubrious and menacing climate. Prokofiev claimed music could be made under any conditions, for any patron, in any style: happiness can be simulated so effectively that even the most suspicious censors can be taken in, however calm or distraught you are. He’s always smiling in the photographs, the only Soviet composer not to skimp on smiles during those dismal decades. It is as if he were smiling for others because for him music is not a heart-rending vehicle of truth but a sophisticated, perhaps somewhat childish game, where the winner is the one who looks least serious. Anyway, it wasn’t Prokofiev I wanted to talk about.
Many great composers of allegros looked despondent: I don’t mean Beethoven’s scowl, reproduced in thousands of piano-top busts, but long faces like that of the Swede Franz Berwald (1796-1868), who also wrote allegros that were not only beautiful and festive but also “fuocoso”, as his notation indicates. You look at the daguerreotypes and wonder: did he ever smile? In the family, with friends, would the edges of his lips ever have curved into a suppressed snicker after a good joke over dinner washed down with the right wine? And in these convivial circumstances, would he himself ever have made a quip of the kind that is greeted with a benevolent chortle? I know: back then, exposures were long and no one ever laughed in photographs because it was not the custom and because no one would be able to keep up a smile for that long while waiting for an impression to form on a plate. Everyone looked solemnly funereal, even the children, to the point that it was almost impossible to distinguish the living from the dead, whose pictures were often taken alongside the living after applying the right amount of makeup. Still, Berwald’s expression seems to say: the world is so gloomy that laughing would be obscene, sinful, morally degenerate.
There were, in fact, a few reasons for the good Berwald to be upset: although he came from a family of musicians, he was self-taught as a composer, ignored by academic circles until the end of his life, and forced into professions that had nothing to do with music (orthopaedics, glass-blowing). Travelling around Europe, he absorbed the innovations of the time, mastered the symphony form by combining classicism with romantic disquiet, and experimented with symphonic poems — ultimately becoming a progenitor of the Scandinavian symphony. There are light-hearted pioneers in the history of music, of course. Ives, who worked all his life in insurance, wove his complex patchworks almost completely alone and totally ignored by the world, always with a smile. Villa-Lobos laughed all the time; he laughed and smoked a cigar even when he was wearing a powdered wig like Bach. Berwald, on the other hand, resented the narrow provincialism of his origins, which condemned him to living on the periphery, with his ears constantly pricked up to glean the latest fashions from afar. Above all, he found it hard to persuade his own audiences to appreciate his vision. He was original and daring and he knew it. But he also knew that no one at home or anywhere else would understand him. Listen to the instrumental finesse of the allegro fuocoso that opens his Third Symphony in C major, the Singulière. Relish the beautiful exposition of the themes and abandon yourself to the unpredictable way they are developed. Or delight in the allegro (with no modifier) of the second Symphony in D major, the Capricieuse, with its simple rising and dipping theme like a children’s song you could listen to over and over again: taa-tatatataa-tatatataa-tatatataa-tatatataa. Picture our Franz at home in Stockholm, where he returned in 1842, hunched over his score as he scribbles in the notes. Relatives and friends skate around him: he looks so fretful they may well think he is composing a Requiem, for himself, perhaps. And yet, when he goes to the piano to try out the melodies and repeats certain passages to the point of exhaustion, singing along to himself, there’s no great drama. Rather, they hear a playful, comical sequence (taa-tatatataa-tatatataa…). This worries them.
Are you alright, dear man? they ask.
He stops humming and mutters something in response.
Are you alright? they ask again a little later.
No, he growls, I am not alright, nothing is alright! In the meantime, the fingers flying over the keyboard appear to contradict him and say that somewhere, in another layer of reality that could never be put into words, everything is just fine, and the music conjures up dancing, courting lovers tripping through dewy meadows, throwing kisses and caresses at each other (taa-tatatataa-tatatataa…).
Nothing is alright! Berwald yells, screwing up his sky-blue eyes because in protest at the disturbance. And the motif that has just flashed through his mind is slipping away. In fact, it has already gone. And it was beautiful. If possible, even more beautiful than taa-tatatataa-tatatataa, it was rapturously sweet, a balm for all the pains of the world. He runs back to his score to capture it on paper. In vain: the bunched-up black notes are nothing like the theme. He angrily scratches black crosses on the notes to erase them.
Music goes one way, reality another. Berwald clings to the fleeting motif like a runaway to a drainpipe, while below, in the dark alley, some onlooker is waiting for it to crack. Berwald’s grimace reflects the effort of hanging on to a creaking gutter feeling his strength is about to run out, which makes him grit his teeth and look back on the life he might have lived if the world had been brightly coloured rather than gray and miserable. The tricks music plays.
Dissonances and daring modulations are more splashes of colour. In the solitude forced on him by the incomprehension of his contemporaries, Berwald intensifies contrasts and extremes, alternating between empty and full, static and dynamic, simple and complex, conventional and paradoxical, peaceful and martial, like an out-of-control Beethoven who is blind as well as deaf. His allegro is far from blithe. It is a thousand things at once: it is the beauty of something bizarre, bristly, obscure. Berwald’s family members cannot get their heads around those clashes, those discordant clots of sound, those rash yet halting ventures into uncharted territories. Their idea of music is different. It belongs, as it were, to the polite realm of the drawing-room, while poor Franz, since returning from his travels in Europe, has been experimenting with abrasive, undisciplined sounds. His allegros are by no means bucolic. They are unbridled barbarism.
What’s happened to you, dear man? they ask in a whisper. He does not answer. He could reply that Liszt once spoke well of him and that von Bülow, on another occasion, had said he appreciated his music: but he has already played these cards and if he goes on repeating these concepts, which everyone has already silently cast doubt on, they might take him for a fool.
He composes and composes and makes several copies of his works. From early jottings he moves on to scores with more regular notations, creating an illusion of printed sheet music because no one has yet been willing to publish his music and no one will in his lifetime. Every now and again, someone from the family offers to copy out a few pages for him, just to give him a rest so that he can look out of the window and gaze at the Stockholm sky where those endless sunsets look like endless sunrises: but he refuses, mutters that the difference in handwriting might be noticed and then he would have to start from scratch. If anyone asks him about the orthopaedic clinic where he works, on the other hand, his gaze turns watery and detached: the hernial support belts he works with are transformed into incomprehensible, intimidating and monstrous contraptions, the kind of thing that should be left to early morning dreams, the most bizarre ones.
In the evening, however, when he is alone, he stands in front of a mirror and practices distending his furrowed brow and lifting the muscles of his cheeks and lips for when some important institution finally acknowledges his merits and gratifies him with accolades. But all he can produce is a grotesque grin, a grimace that would upset the ladies, offend the men, and make the children cry.
*
“Allegro ma non proprio”
Chi pratica la musica sa che l’Allegro, con cui si aprono e si chiudono sonate e sinfonie, quartetti e concerti, non è proprio allegro, cioè non dichiara o impone o suggerisce uno stato d’animo, ma piuttosto una velocità. Ci sono Allegri di tormentosa inquietudine, altri di frenetica drammaticità – e a nessuno verrebbe in mente di trovarci qualcosa di allegro.
Certo, esistono sempre compositori come Prokof’ev. Anche nelle opere più celebrative, i suoi Allegri suonano sinceramente gioiosi come se davvero si potesse sorridere, o fingere di sorridere, il che era spesso la stessa cosa nell’ambiente tetro e minaccioso in cui viveva. Secondo Prokof’ev si può fare musica a qualunque condizione, per qualunque committente, in qualunque stile: e non importa se si è sereni o angosciati, si può simulare così bene la felicità da riuscire a convincere anche i censori più sospettosi. Nelle fotografie sorride sempre. È l’unico compositore sovietico a non lesinare sui sorrisi in quei decenni foschi. È come se sorridesse per tutti gli altri, perché per lui la musica non è un linguaggio lacerante di verità, ma un gioco elegante, anche un po’ infantile, in cui vince chi non fa la faccia seria. Ma non è di Prokof’ev che voglio raccontare.
Grandi compositori di Allegri avevano volti lugubri: non parlo del cipiglio di Beethoven riprodotto in migliaia di erme da tenere accanto al pianoforte, ma di musi lunghi come quello dello svedese Franz Berwald (1796-1868), che pure ha scritto Allegri di festosa, “fuocosa” (come scriveva lui) bellezza. Guardi i dagherrotipi che lo ritraggono e ti domandi: avrà mai sorriso? In famiglia, con qualche amico, avrà mai sollevato i bordi delle labbra per abbozzare una mezza risata dopo una buona battuta, durante una cena innaffiata dal vino giusto? E lui, di suo, in tali occasioni conviviali avrà mai detto una scempiaggine di quelle che si accolgono con benevola ilarità? Lo so: allora i tempi di posa erano lunghissimi e nessuno rideva mai nei ritratti fotografici, perché non si usava e perché nessuno sarebbe riuscito a mantenere il sorriso per tutti quei minuti in attesa dell’impressione della lastra. Tutti erano severi, funerei, anche i bambini, al punto che era pressoché impossibile distinguere i vivi dai morti, che era consuetudine fotografare accanto ai primi dopo un’adeguata seduta di trucco. Eppure, il volto di Berwald sembra dire: il mondo è così cupo che ridere è un atto sconcio, è un peccato, una miseria morale.
In effetti, motivi per innervosirsi ne aveva, il buon Berwald: anche se veniva da una famiglia di musicisti come compositore era un autodidatta, ignorato dagli ambienti accademici fino agli ultimi anni della sua vita, costretto a professioni remote dalla musica (medicina ortopedica, fabbricazione del vetro). Viaggiando in Europa assorbì le novità dei suoi tempi, imparò a padroneggiare la forma della sinfonia coniugando il classicismo con le trepidazioni romantiche, si avvicinò al poema sinfonico, e in questo gran daffare anticipò il sinfonismo scandinavo. Ora, ci sono pionieri spensierati nella storia della musica: Ives, che pure lavorò tutta la vita nelle assicurazioni, tesseva i suoi complessi patchwork con un sorriso, in una solitudine quasi assoluta, nella più profonda indifferenza del mondo; Villa-Lobos rideva sempre, rideva e fumava il sigaro, anche quando si metteva in testa la parrucca incipriata di un Bach. A Berwald invece pesava l’angusto provincialismo del mondo da cui proveniva, la condanna a una vita periferica, il continuo drizzare le orecchie per captare da lontano le novità, e soprattutto la difficoltà a imporre la sua visione alla sua gente. Era originale, audace: lo sapeva, ma sapeva anche che nessuno in patria o altrove lo avrebbe compreso. Ascoltate le finezze strumentali dell’Allegro fuocoso che apre la sua terza Sinfonia in do maggiore, “Singulière”: assaporate la bellezza dei temi, abbandonatevi all’imprevedibile lavorio dello sviluppo; o incantatevi con l’Allegro (e basta) della seconda Sinfonia in re maggiore, “Capricieuse”, con quel tema semplicissimo che va su e giù, come un canto di bambini, daa-dadadadaa-dadadadaa-dadadadaa-dadadadaa, e che vorreste ascoltare all’infinito. Immaginate il nostro Franz nella sua casa di Stoccolma, in cui è tornato nel 1842, chino a scrivere notine sulla partitura, mentre attorno a lui scivolano parenti e amici: lo vedono imbronciato, e pensano che stia componendo un Requiem, magari proprio per sé stesso. Però, quando lui va al pianoforte a provare le parti, e suona e risuona e canticchia certi passaggi fino allo sfinimento, non avvertono nulla di drammatico, piuttosto un ilare succedersi di giocosità (Daa-dadadadaa-dadadadaa…). Questo li preoccupa.
Tutto bene, caro? gli chiedono.
Lui interrompe il canto, a malapena risponde con un mugugno.
Tutto bene? gli richiedono dopo un po’.
Lui ringhia che no, non va tutto bene, non va bene niente! E intanto le sue mani sulla tastiera sembrano smentirlo e dire che, da un’altra parte, in un altro strato della realtà che non si potrebbe mai tradurre in parole, tutto va benissimo, ed è tutto un danzare, un corteggiarsi, un correre per i prati rugiadosi, un lanciarsi baci e carezze (Daa-dadadadaa-dadadadaa…).
Non va bene niente! urla Berwald, strabuzzando gli occhi cerulei perché le gente lo disturba, e quella certa idea che gli è appena venuta in mente gli sta sfuggendo dalla memoria, anzi è già dimenticata. Ed era un’idea bellissima, se possibile ancora più bella di Daa-dadadadaa-dadadadaa, un tema di una dolcezza rapinosa, un balsamo per tutte le pene del mondo. Corre a scarabocchiarla sulla carta da musica, invano: i grappoli di note nere non la ricordano nemmeno alla lontana. Per cancellare gli appunti incide con rabbia delle croci nere sul foglio.
La musica va da una parte, la realtà dall’altra. Berwald si aggrappa alla musica come un fuggitivo alla grondaia di un tetto, mentre sotto, nel vicolo buio, qualche curioso aspetta che si sfracelli. Il cipiglio di Berwald è dato dallo sforzo di chi resta appeso alla grondaia cigolante e sente che le forze stanno per mancare, e allora stringe i denti e passa in rassegna non la sua vita grigia e penosa, ma quella che avrebbe potuto vivere se il mondo fosse a colori sgargianti. Questi scherzi fa la musica.
Anche le dissonanze e i passaggi armonici azzardati fanno parte di quei colori. Berwald, nella solitudine a cui lo costringe l’incomprensione altrui, esalta i contrasti, gli estremi, alterna i vuoti e i pieni, la stasi e la dinamica, il facile e il difficile, il convenzionale e il paradossale, la pace e la guerra, come un Beethoven fuori controllo e cieco oltre che sordo. Il suo Allegro non è allegro: è mille cose insieme, è la bellezza dell’incongruo, dell’irto, del torbido. I familiari di Berwald non si capacitano di quelle dissonanze, di quei grumi irrisolti di suoni, di quell’avventurarsi impetuoso e insieme claudicante in territori inesplorati. La loro idea della musica è diversa, è – come dire – salottiera, beneducata, mentre il povero Franz, da quando è tornato dai suoi viaggi in Europa, sperimenta sonorità spregiudicate, sconce, i suoi Allegri non hanno nulla di bucolico, sono tirate barbariche.
Che ti è successo, caro? gli domandano in un sussurro. Lui non risponde. Potrebbe replicare che una volta Liszt ha detto bene di lui, e che anche von Bülow, in un’altra occasione, si è espresso con favore sulla sua musica: ma ha già giocato queste carte, e potrebbero prenderlo per matto a sentirgli ripetere sempre gli stessi concetti, sui quali hanno già dubitato in silenzio.
Scrive, scrive, e copia più volte le sue opere. Dagli abbozzi passa a partiture dalla grafia più regolare, nell’illusione che assomiglino a fascicoli stampati, perché nessuno ha ancora voluto stampare la sua musica, e nessuno lo farà finché lui sarà in vita. Ogni tanto qualcuno della famiglia si offre di copiare al posto suo qualche pagina, giusto per consentirgli di riposare, di affacciarsi alla finestra e guardare il cielo di Stoccolma, quei tramonti lunghissimi che sembrano albe lunghissime: ma lui rifiuta, borbotta che si noterebbe la differenza di scrittura, e allora bisognerebbe rifare tutto da capo. Se invece gli chiedono della clinica ortopedica in cui lavora, il suo sguardo si fa acquoso e lontano: i cinti erniari di cui si occupa gli diventano aggeggi ostili e mostruosi, dall’utilizzo incomprensibile, qualcosa da relegare nei sogni del primo mattino, quelli più bizzarri.
La sera, però, se è solo, si pone davanti a uno specchio e si esercita a distendere la fronte corrugata e a sollevare i muscoli di guance e labbra, per quando qualche importante istituzione ammetterà finalmente i suoi meriti e lo gratificherà di un riconoscimento. Ma ne vengono fuori soltanto ghigni poco rassicuranti, smorfie grottesche, che turberebbero le signore, offenderebbero gli uomini e farebbero piangere i bambini.
__________________________________
From The Florence Review. Used with permission of The Florence Review. Copyright 2023 by Claudio Morandini, translation copyright by Clarissa Botsford.